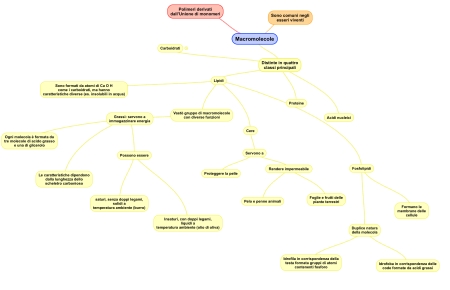Nell’undicesimo canto troviamo i superbi, che espiano il loro peccato sulla prima cornice pregando e trasportando pesantissimi massi. E’ la mattina dell’11 aprile (o forse del 28 marzo) 1300, il lunedì dell’angelo.
Tutti i superbi recitano una versione leggermente modificata del Padre Nostro, e quando Virgilio domani la strada più breve per la cornice successiva, perché deve salire un vivo, a rispondere è l’anima di Omberto Aldobrandeschi, membro di nobile famiglia toscana.
Non si sa se sia morto in battaglia o in un agguato dei senesi, di cui era nemico, e menziona il padre (Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre) forse per presentarsi in modo più umile, o forse per chiarire chi gli ha procurato il potere e l’arroganza.
Omberto non chiede favori o altro, e pare volersi assumere tutto il peso della sua colpa
E qui convien che questo peso porti
per lei, tanto che a dio si soddisfaccia,
poi ch’io non fe’ tra ‘ vivi, qui tra ‘ morti
Vedendo un altro personaggio che si torce per guardarlo Dante, a sua volta chino per implicita confessione dello stesso peccato, riconosce il celebre miniatore Oderisi
l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte
ch’alluminar chiamata è in Paris
Oderisi da Gubbio risponde notando che ora sono più apprezzate le illustrazioni di Franco Bolognese, con una cortesia che se fosse arrivata prima avrebbe risparmiato un po’ più di sofferenza in Purgatorio.
Vengono menzionati Giotto e Cimabue, Cavalcanti e Guinizelli come esempi della massima sic transit gloria mundi, e con l’aggiunta che forse qualcuno, magari Dante?, avrà fama maggiore dell’uno e l’altro Guido.
Dopo le note terzine sull’insignificanza della fama di fronte allo scorrere del tempo (mill’anni, meno che un muover di ciglia), Oderisi parla di un penitente che cammina poco innanzi a lui: ne parlava tutta la Toscana, e ora a pena in Siena sen pispiglia.
Si tratta di Provenzan Salvani, signore e padrone di Siena, che ha diritto a una riduzione di pena per essersi umiliato chiedendo l’elemosina ai suoi concittadini in piazza del Campo, allo scopo di riscattare un amico prigioniero del re Carlo d’Angiò.
E come lui si condusse a tremar per ogne vena, profetizza in modo oscuro Oderisi, così i tuoi concittadini faranno sì che tu potrai chiosarlo.
Nel dodicesimo canto Dante vede esempi di superbia punita, scolpiti a terra come si può vedere nelle tombe dell’epoca, e sono parecchi. Il primo e più importante, considerato (vv.25-27) è Lucifero, giù dal cielo folgoreggiando scender.
Si passa poi ad esempi tratti dalla mitologia: il gigante Briareo colpito dal fulmine di Giove (vv.28-30) poi Apollo (Timbreo), Pallade e Marte che contemplano orgogliosi la strage di giganti (mirar le membra d’i Giganti sparte, vv. 31-33).
A seguire, esempi biblici e mitologici: Nembrot o Nimrod costruttore della torre di Babele; Niobe, madre troppo orgogliosa dei suoi quattordici figli e per questo punita dagli dei (Apollo e Artemide) con la loro uccisione.
Saul, sconfitto dai Filistei e suicida perché insuperbito del potere concessogli da dio. Aracne, tessitrice tanto arrogante da sfidare una permalosa Atena, che alla fine la trasforma in ragno, costringendola così a filare per tutta la vita.
O folle Aragne, sì vedea io te
già mezza ragna, trista in su li stracci
de l’opera che mal per te si fé
Roboamo, re d’Israele dopo Salomone, con i suoi soprusi provoca la rivolta e la divisione del popolo. Poi c’è Erifile uccisa dal figlio Alcmeone; l’empio Sennacherib re d’Assiria, autore del palazzo senza eguali, citato nella Bibbia, ucciso (forse) dai figli.
Appare la testa mozzata del crudele re Ciro II di Persia immersa nel sangue, e la fuga degli Assiri con il corpo di Oloferne, il loro condottiero decapitato da Giuditta. Infine, l’esempio emblematico della superbia punita è dato dalle rovine fumanti di Troia.
Dante si chiede chi potrebbe aver creato queste opere stupende,
Morti li morti e i vivi parean vivi:
non vide mei di me chi vide il vero,
quant’io calcai, fin che chinato givi
e conclude la descrizione con un’invettiva sarcastica contro i superbi figliuoli d’Eva, che non abbassano il capo a riflettere sui loro errori, e via col viso altero.
Assorto in questa contemplazione Dante perde un po’ la cognizione del tempo passato e dello spazio percorso, quindi Virgilio lo invita ad atteggiarsi umilmente perché si avvicina l’angelo dell’umiltà che agevola la salita di Dante alla seconda cornice.